“La casa degli sguardi” di Daniele Mencarelli. La paura di vivere, il sentirsi preda di sensazioni che attanagliano l’anima, rinchiudersi in un mondo, dominato dall’alcol che lo annienta e non gli dà la possibilità di pensare, di trattenere i ricordi, mentre la presenza di sua madre, addormentata sui tre gradini che portano alla sua stanza, in perenne attesa di un cambiamento, di un miracolo, è come se lo bloccasse e, nello stesso tempo, gli facesse desiderare di fuggire. Lei è ferma lì, non se la sente di abbandonarlo al suo destino, continua a sperare, mentre egli si rende conto della “vecchiaia che sta dando a sua madre” e al dolore che provano i suoi genitori.
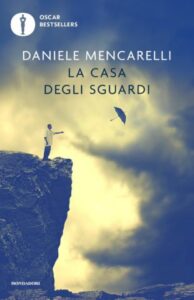
Daniele, il protagonista, si sente in gabbia, ha una terribile consapevolezza: “il male sono io”. Viene assunto come operaio ed è la prima volta che deve affrontare da sobrio un dialogo con un altro essere vivente e ha paura. Il “bicchiere di bianco” rappresenta per lui l’unica via di salvezza: l’alcol è un’onda di morbidezza, fa sparire gli spigoli, quelli al cui contatto ci si può ferire. Ha sperimentato la catena della dipendenza e non riesce a proteggersi da nulla; la presenza dei suoi genitori è come se appartenesse a un altro mondo, perché ormai essi “parlano una lingua senza suoni”. Il lavoro gli appare come una realtà altra, quasi come una sfida, lo vive con impegno, anche nel pulire parti molto sporche, poiché è come se volesse togliere lo sporco anche da se stesso, sente che deve riuscirci assolutamente. L’ospedale Bambino Gesù è un luogo di tortura, un posto che vince su ogni altro dolore. Un momento fondamentale del suo percorso di vita è l’incontro con “Toctoc”, un bambino che lo guarda e gli fa dei cenni e poi lo chiama “COR-NU-TO”, mentre Daniele lo osserva attraverso il vetro e legge dalle sue labbra. Pian piano egli comprende che è una nuova possibilità che la vita gli ha dato: è difficile per lui rinunciare all’alcol, fatica a tenere a bada i suoi tremori. La solitudine è per lui una compagna, ma anche una gabbia da cui non riesce a scappare, ma comincia a tessere rapporti con i suoi colleghi della cooperativa, anche se l’aiuto che non riesce a dare gli fa provare un senso profondo di fallimento. L’attaccamento al lavoro, “lo sgrosso”, lo uccide ma a volte lo fa ridere di una spensieratezza mai avuta prima, con la monospazzola di cui diventa esperto. Il contatto con la sofferenza, gli innumerevoli visi di genitori dietro i vetri che guardano i loro figli e la ”casetta dei bambini morti” scatenano in lui furia e disperazione. La felicità nel ritrovare “Toctoc” e nello stesso tempo il senso profondo di egoismo perché avrebbe dovuto desiderare che fosse finalmente dimesso lo turbano profondamente: il sorriso che gli rivolge, nel suo pigiamino grigio che sembra diventato di due taglie più grandi si lega all’ indecifrabile destino di tanti bambini. A volte Daniele non vorrebbe ricordare nulla, perché in alcuni momenti diventa il ”testimone di ciò che compio in mia assenza” e lì dentro si comincia a sentire parte del tutto, soprattutto nel rapporto con Massimo in cui non c’è bisogno di parole. Si reca a una lettura di poesie: è la passione che gli riempie la vita, ma le sue giornate sono fatte anche di impegno nel portare avanti il suo lavoro nella cooperativa. Qualcosa è cambiato in lui e si rende conto che rinunciare al lavoro al Bambin Gesù vorrebbe dire “perdere l’unico spazio in cui la mia voce esce autentica, con tutto il carico di amore e incapacità di vivere che sconto ogni giorno”. L’aggressione che subisce da parte di alcune persone, mentre è sotto i fumi dell’alcol a poco a poco gli fa capire che i suoi genitori stranamente sono le uniche cose che lo tengono in vita e lo proteggono e che ci sono ancora “primizie da vivere”. Decide di rinunciare all’alcol e ripensa alle parole di sua madre: “Io ti ho fatto nascere, ma rinascere spetta solo a te”. Si rifugia in mezzo alle persone e propone al presidente dell’ospedale un’antologia di poeti provenienti da varie nazioni, ma egli lo spinge a scrivere un libro di poesie che parla delle esperienze in ospedale. E’ l’ennesima sfida, un altro muro da valicare e la prima parola che gli viene in mente è “orrore”; comincia a scrivere: un ammasso di suoni indistinti e rumori, la voce dell’ospedale. Non riuscirà tuttavia a scrivere di “Toctoc”, di cui alla fine scoprirà il suo vero nome, Alfredo, solo dopo la sua morte, che lo addolorerà profondamente. Il presidente gli dice che, pur vivendo tantissime ore in ospedale, ha iniziato a conoscerlo solo grazie a lui e alle sue poesie: egli prova emozione, perchè è riuscito ad andare dietro a tutti i ricordi, nonostante sia consapevole che “ci saranno tanti bambini che non ce la faranno”. Egli si sente di “appartenere a quelli salvati da quest’ospedale” e ora vuole ricordare tutto.
A cura di Ilde Rampino
















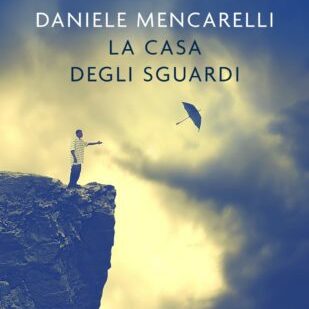






ARTICOLI CORRELATI